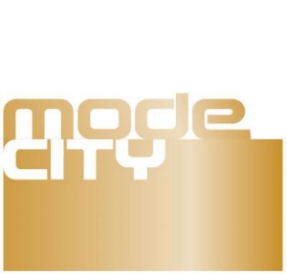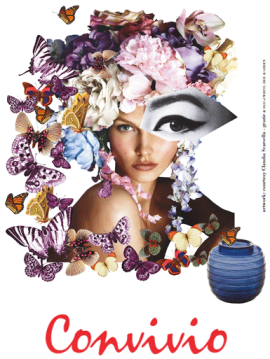Archive
Wallis Simpson, arti e mestieri della Duchessa di Windsor

Yves Saint Laurent, maestro indiscusso della moda internazionale

Il 1 agosto 1936 nasceva Yves Saint Laurent, maestro indiscusso della moda internazionale. Tre lettere sovrapposte: Y S L. La griffe leggendaria dell’Haute Couture prosegue il suo viaggio inarrestabile anche dopo la scomparsa del suo creatore, Yves Saint Laurent. Marrakech ha onorato il maestro qualche anno orsono, con una restrospettiva dedicata ai lavori ispirati dal Marocco (una quarantina, oltre ad audiovisivi, immagini e oggetti). Un omaggio dovuto; qui lo stilista ha vissuto dal 1967 sino alla sua morte nel 2008 e le sue ceneri sono state sparse nel giardino Marjorelle che tanto ha amato. Un viaggio straordinario quello di YSL che dalla natia Orano, Algeria, lo porta a Parigi nel 1954, dove inizierà il suo viaggio immaginario e immaginato intorno al mondo. Nel 1967 la Maison festeggiò i suoi primi cinque anni di esistenza, coronati di successi e di importanti riconoscimenti alle collezioni definite allora “geniali”. Flirtando con le arie di quei tempi sotto forma di New Look (1962), abiti Mondrian (1965) o cappotti Pop Art (1966), Yves Saint Laurent moltiplicava i suoi sguardi meravigliati sull’arte e sulla cultura del mondo. Nel gelido inverno parigino del 1967 la svolta che lo impose come “ineguagliabile“: primo viaggio con abiti per principesse nubiane dei tempi moderni, chiamati “Bambara“, lavorati quasi al microscopio sulle indossatrici con audaci trasparenze realizzate con finissimi fili di perle. Era l’epoca swinging sixties e la crescita di una nuova cultura, quella della gioventù. L’Haute Couture con i suoi taillleurs, i suoi twin-set, rispondeva a delle convenzioni che stavano sparendo, tea time, cocktail time, ecc.. In quei tempi di grandi cambiamenti la collezione africana di Yves Saint Laurent soffiava come un vento di passione sui cuori ingordi di novità, a colpi di frange in rafia bluette e batiks coloratissimi. Proponeva in primis un’altra idea del lusso, meno ostentato e più vicino al soffio di libertà dell’epoca, la ricchezza del “mondo è nostro“. In questo gli abiti Bambara furono degli autentici fuochi, l’incarnazione di una bellezza senza regole, fatta di spirito e sostanza provocatoria . L’impronta dei costumi tradizionali africani non era solo un flash, una piega alle tentazioni esotiche primarie, ma un appello aperto al metissaggio dei sensi, un gesto estetico perfettamente incarnato dalle modelle nere che possedevano quello che di più magico puo’ avere una donna: il mistero. Non il vecchio mistero incarnato dalle femmes fatales, ma il mistero dinamico delle donne attuali (1).
L’anno seguente la collezione Safari Look dove nacque la mitica “sahariana”. Nel 1976 la collezione “Balletti russi“, considerata dal suo creatore come una delle più belle in assoluto. Poi la superba “Collezione cinese” che rivisitava i classici imperiali in salsa Paris chic, ad immagine del profumo Opium lanciato nel 1977. Seguirono delle collezioni spagnoleggianti che potremo sottotilolare “Corrida d’Amore”, come nel film di Nagisa Oshima, e ancora collezioni marocchine, indiane, un tourbillon sontuoso di colori e di citazioni che riapparsero periodicamente sino al ritiro dell’Haute Couture dalla Maison. Il matrimonio era consumato: Yves Saint Laurent amava il mondo e il mondo amava Yves Saint Laurent. Dal 1983 le retrospettive si sono moltiplicate, 83 in Usa, 85 in Cina e in Russia ben 87. Ma il periodo più fecondo e spirituale prese vita nel 1967 quando avvenne l’incontro decisivo: il suo coup de foudre per il Marocco. Se Orano aveva donato allo stilista un apertura di paradiso perduto, con Marrakech Yves Saint Laurent ritrovò l’eden, la luce. Fu in quel momento che prese piena coscienza del potere dei colori, delle loro potenzialità violente e infinite. Marrakech divenne il suo eremo, un luogo di incontri, la sua fonte di ispirazione. Pierre Bergé dichiarò che “quando scoprirono il Marocco, compresero che il suo cromatismo era quello degli zellijges e degli zouacs, dei hjellaba e dei burnos“. (2) Dopo aver vissuto per una decina di anni nel Dar el Hach, la casa dei serpenti, Yves Saint Laurent e Pierre Bergé acquistarono nel 1980 la villa Majorelle, appartenuta al pittore omonimo. Il blu presente all’interno della proprietà sarà l’anticamera dei “viaggi immobili” dello stilista. Le luci, i colori, le piante, i giardini, la frutta e le spezie saranno una fonte di interpretazione cromatica, sempre più ricca e sorprendente, tradotta in tessuti esclusivi forniti da un complice fedele della Maison, lo svizzero Zumsteg, che attraverso una serie di collezioni superbe offrirà a YSL tutte le tecnologie esistenti in campionature di tessuto con stampe uniche e inimitabili. Il caftano, vestito folk marocchino, trovò una dimensione universale quando venne presentato accompagnato da una preziosa cappa in passamaneria, con broccati lamés, graffiato con tessuti da sera, stampato a disegni floreali o animalier. Lontano dall’essere pretestuoso o svincolante, si proponevano comunque strutture classiche dando diverse alternative agli stereotipi, con l’aiuto di colori proibiti o tagli irregolari. Yves Saint Laurent amava profondamente le donne e le voleva libere nel senso più spirituale e intimo del termine, giocando con l’ambiguità dei sensi e delle forme in un bluff gioioso e alternativo. Fu pioniere nella materia, democratizzando il costume maschile in tutta femminilità, osando le vere trasparenze senza mai pero’ entrare nella volgarità provocatoria di una sessualità esplicita. La maggiorparte dei suo pezzi immaginati per quel “viaggio straordinario” sono dotati di una sensualità animale emanata dalle macchie del leopardo, dal calore della seta e del velours, una eccezione colorata della lotta tra Eros e Thanatos. Margherite Duras disse di Yves Saint Laurent che non faceva “della differenza tra le cose che creava per gli uomini e quelle che creava per gli dei“. (3)
(1) David Teboul, Yves Saint Laurent, 5 avenue Marceau, Edizioni de la Martinière, Parigi 2002
(2) Catalogo dell’Esposizione Yves Saint Laurent: exotisme. Insieme dei Musei Nazionali, Parigi 1993
(3) Yves Saint Laurent e la fotografia di moda, Albin Michel, Parigi 1998
Fonte: My Amazighen
Piermario Morosini
Piermario Morosini (Bergamo, 5 luglio 1986 – Pescara, 14 aprile 2012) è stato un calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
È scomparso il 14 aprile 2012, a soli 25 anni, in seguito ad un’improvvisa crisi cardiaca durante l’incontro di Serie B Pescara-Livorno.
Biografia
Rimane orfano giovanissimo: nel 2001 a 15 anni perde la madre Camilla e due anni dopo il padre Aldo. Nel 2002 si suicida il fratello disabile, e Piermario rimane solo con una sorella anch’ella disabile.
La prematura morte
Il 14 aprile 2012, al 31′ di Pescara-Livorno, gara valida per la 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, muore per un’improvvisa crisi cardiaca. Dopo la sua morte la FIGC ha disposto il rivio della singola partita e dell’intera giornata di tutti i campionati italiani.
Carriera
Club
Tira i primi calci nella Polisportiva Monterosso, squadra di quartiere di Bergamo. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, dove nei dieci anni di militanza riesce a vincere uno scudetto Allievi, nel 2005 passa in compartecipazione all’Udinese, dove a 19 anni gioca la prima stagione da professionista dividendosi tra Primavera e prima squadra nella stagione 2005-2006, collezionando 5 presenze in Serie A. L’allenatore Serse Cosmi lo fa esordire il 23 ottobre in Udinese-Inter. Gioca anche 3 partite in Coppa Italia e una in Coppa UEFA, precisamente l’ottavo di finale Levski Sofia-Udinese. Nella stagione 2006-2007 passa al Bologna, in Serie B, dove scende in campo in 16 occasioni.
Nel luglio 2007, riscattato dall’Udinese, passa al Vicenza, in Serie B, dove con la squadra veneta conquista la salvezza contribuendo con 34 presenze e un gol. A fine annata il Vicenza ne riscatta la metà del cartellino, quindi gioca altre 32 partite.
Nell’estate del 2009 l’Udinese riscatta la metà per una somma pari a circa 1,5 milioni di euro.
Il 31 agosto 2009 passa in prestito alla Reggina.
Il 1º febbraio 2010 passa con la formula del prestito con diritto di riscatto della compartecipazione al Padova. Il 6 febbraio debutta con i biancoscudati in Piacenza-Padova (1-0). Il 23 giugno 2010 il Padova comunica di non aver escercitato il diritto di opzione sul cartellino del giocatore.
Nel gennaio del 2011 passa in prestito al Vicenza.
Il 31 gennaio 2012 passa al Livorno.
Nazionale
Dopo aver fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, esordisce nella Nazionale Under-21 nel settembre del 2006. Fa parte del biennio 2007-2009 degli Azzurrini della squadra con cui partecipa all’Europeo Under-21 del 2009 in Svezia.
Fonte: Wikipedia
Nevada, garage sotterraneo in villa di gran lusso
Di auto e moto sportive e di lusso, non è la prima volta che se ne parla, ma quello che stiamo per vedere ora è un qualcosa di davvero inimmaginabile, tanto che sembra un vero e proprio effetto cinematografico, quando invece e pura realtà.
Esemplari di ogni genere, a dir poco si sprecano in questa mega-villa di lusso del Nevada, che oltretutto comprende ambienti di grande pregio e tutte le amenità che un uomo possa desiderare, allestiti in maniera fortemente lussuosa, con un pizzico di sfarzo che rende il tutto meno monotono allo sguardo.
Nel video di seguito, potrete infatti ammirare alcuni di questi ambienti e, come si può intuire dal titolo dell’articolo, potrete visionare con i vostri occhi questo assurdo garage di lusso, dal valore complessivo di 6 milioni di dollari; si tratta di una sorta di ascensore a scomparsa con un meccanismo molto ricercato che, secondo quanto rivelato dal proprietario, consuma 25 dollari di corrente ogni volta che viene attivato.
Fonte: GoLook.it
Charles Eugène de Foucauld de Ponbriand
Il visconte Charles Eugène de Foucauld de Ponbriand vide la luce a Strasburgo il 15 settembre 1858 da una famiglia nobile che diede santi alla Chiesa e militari alla Francia. Morì assassinato nel suo eremo sahariano il primo dicembre 1916. Adolescente delicato, effeminato, intelligente e capriccioso, perse la fede all’età di 16 anni quando fece il suo ingresso al liceo di Nancy. Bibliofilo e gastronomo passò alcuni anni nell’Accademia Militare dedicandosi però ai godimenti della vita. Come ufficiale del IV° Cacciatori d’Africa arrivò in Algeria nel 1880 preceduto da una fama di vizioso, ubriacone e immaturo. Tutti quanti erano a conoscenza che il suo diploma fu quasi un obbligo verso la sua nobile famiglia , una delle più ricche di Francia. A Sétif proseguì la sua vita frivola ed ebbe il suo primo contatto con l’Africa e l’Islam, contatto che lo soggiogò al deserto. In discrepanza con i suoi collegionari volle conoscere la tribù dei ribelli Khumir, che vivevano a sud di Orano, dopo l’ insurrezione voluta dal marabout Bou-Amama. Questo gruppo etnico aveva marcate differenze con gli arabi e, a quel punto, Foucauld prese a studiarli. La ricchezza linguistica, l’organizzazione sociale, i riti e i costumi preislamici, lo affascinarono enormemente. Grazie alla sua condizione di militare potè penetrare nel territorio prendendo nota della loro vita, senza nessun incidente rilevante. Ebbe inizio il suo primo vero lavoro da esploratore in campo. Per la sua indisciplina e la latente maleducazione venne in seguito espulso dall’esercito e tornò in Francia, riammesso poi in servizio sino alla fine del 1881. Chiese poi un permesso per entrare in un territorio inesplorato e gli venne negata l’autorizzazione. A quel punto decise di viaggiare come civile e lasciò l’esercito. L’incontro con Oscar Mac Carty, custode della biblioteca di Algeri e geografo, aprì la strada ai suoi progetti per il futuro. Il Marocco era una terra poco conosciuta, quindi si preparò ad affontare un Paese impenetrabile e pericoloso, in special modo per un cristiano. Studiò per un anno l’arabo e l’ebreo, la religione islamica e le poche informazioni che aveva a sua disposizione. La famiglia era in ansia ma decise di finanziare al giovane la spedizione, convincendosi della serietà e dell’impegno intrapreso.
Foucauld si autoimpose un processo di purificazione fisica e spirituale, di sacrificio e di conoscenza interiore. La sua preparazione tecnica venne svolta con passione, sin dei minimi particolari. Nel giugno 1883 il viaggio ebbe inizio, accompagnato dalla guida rabbina Mardoché Abi Serur. In undici mesi, all’età di 25 anni, percorse quasi 4.000 Km dei quali 2.500 completamente sconosciuti dai geografi, determinando 45 longitudini e 40 latitudini, arrivando nei suoi percorsi sino a 3.000 mt di altitudine. Il suo apporto alla cartografia del Marocco fu straordinario. Foucauld lasciò il Marocco trasfigurato sia mentalmente che fisicamente e scrisse:” L’Islam ha prodotto in me un profondo cambiamento (…) la vista di questa fede, di queste anime viventi nella continua presenza di Dio, mi ha fatto intravedere qualcosa di più grande e di più vero che le occupazioni mondane.” A febbraio del 1886 prese in affitto un appartamento a Parigi per redigere minuziosamente il libro “Conoscenza del Marocco 1833-1884” (Viaggio in Marocco). Vivrà quel periodo austeramente come un musulmano, leggendo il Corano e molti altri testi islamici, vestendosi e nutrendosi nello stile berbero, in una casa priva di mobili. Cercò Dio in una continua inquietudine spirituale e, a quel punto, la famiglia inviò in suo aiuto un padre spirituale, che lo indusse ad una conversione paolina. L‘ostacolo insormontabile era dato dalla combinazione di preghiere cattoliche con il Corano, pratica che il suo nuovo direttore spirituale gli proibirà immediatamente. Ebbe inizio un cammino ascetico che lo vedrà in Siria, Palestina e nel Sahara. Seguì la luce della Bibbia e dell’Islam ed il Marocco restò sempre presente nella sua vita con un amore immenso verso la sua gente. L’opera di Charles de Foucauld è generalmente conosciuta per il suo aspetto religioso. La trasformazione da ufficiale mondano ad ascetico rigoroso, la fulminante conversione al cattolicesimo con l’eremitismo sino alla morte, hanno prodotto una moltitudine di biografie di tipo “vocazionale“, che hanno deformato la realtà, caricandola solo degli aspetti prettamente spirituali, secondo convenienza, perdendo di vista il valore della sua opera scientifica, come etnologo e linguista. Foucauld è stato utilizzato con passione dai cattolici colonialisti e dai musulmani anticolonialisti grazie alla sua vita singolare di cattolico, calata in un innegabile islamismo. Oltre a “Reconnaisance au Maroc” del 1888, Charles de Foucauld ha lasciato numerosi documenti scientifici che ha pubblicato l’Università di Algeri, e gli ” Scritti spirituali“. Nel 1925, Andrè Basset ha publicato in due tomi distinti le poesie che vennero poi tradotte dopo la sua morte. Nel 1951 la tipografia nazionale di Francia, con il contributo del Governo generale dell’Algeria ha pubblicato il dizionario touareg-francese completo, in quattro volumi. ”Reconnaisance au Maroc” è un libro splendido, una vera guida che sotto certi aspetti è ancora valida oggi. Tutto il vissuto di quei mesi è meticolosamente descritto, sin dei minimi particolari; usi e costumi dei villaggi che incontrava, paesaggi e meditazioni. Nel libro sono inseriti disegni di montagne e vallate che l’esploratore vide durante il suo percorso, oltre ad alcune fotografie d’epoca. Morì martire, assassinato da un colpo di fucile il 1 dicembre 1916, per volere di alcuni ribelli senoussi davanti all’ingresso del suo eremo, costruito nel 1911 sulla piana di Assekrem, a 2.780 mt di altitudine, nella regione dell’Hoggar, a 80 Km da Tamanrasset, nel sud algerino. Le sue spoglie riposano, dal 26 aprile 1929, a El-Golèa, chiamato oggi El Méniaa.
Paolo Pautasso
Fonte: My Amazighen
Luca Cordero di Montezemolo
Luca Cordero di Montezemolo (Bologna, 31 agosto 1947) è un dirigente d’azienda italiano.
Presidente della Ferrari S.p.A. (dal 1991) di cui è stato anche Amministratore Delegato (fino a settembre 2006), presidente della FIAT S.p.A. (dal 2004 al 2010), della Fiera Internazionale di Bologna, ex presidente della Luiss (dal 2003 al 2010) e di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori); Consigliere di Amministrazione del quotidiano La Stampa, del Gruppo francese PPR SA (Pinault/Printemps Redoute), Tod’s, Indesit Company, Campari, ex presidente della Maserati (dal 1997 al 2005). Fa parte del Consiglio Direttivo e della Giunta dell’Assonime. È membro dell’International Advisory Board di Citi Inc.. Ha fondato Charme, fondo finanziario imprenditoriale, con cui nel 2003 ha acquisito Poltrona Frau SpA, azienda di arredamento di cui è anche consigliere di amministrazione, e, nel 2004, Ballantyne, marchio internazionale di cashmere, cui si sono poi aggiunti i marchi Cappellini, Thonet e Gufram.
Ha ricoperto in passato gli incarichi di presidente della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e degli Industriali della Provincia di Modena, consigliere di amministrazione di Unicredit Banca d’Impresa, TF1, amministratore delegato della RCS Video, della Cinzano International e della Itedi.
È stato presidente di Confindustria dal 25 maggio 2004 al 13 marzo del 2008.
È presidente di Telethon dal 20 giugno 2009, anche se la nomina del Consiglio di Amministrazione è del 7 luglio successivo.
Nel luglio del 2009 è cofondatore dell’associazione Italia Futura di cui è l’attuale presidente.
Biografia
Primogenito dei tre figli di Massimo Cordero dei marchesi di Montezemolo (Rosignano Marittimo 23 dicembre 1920 – Roma 14 maggio 2009) e di Clotilde Neri (nata a Bologna il 26 agosto 1922) Luca di Montezemolo appartiene ad un’antica famiglia piemontese per generazioni al servizio di Casa Savoia, della quale sono rappresentanti il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo e il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, vittima alle Fosse Ardeatine.
Gli studi e le attività sportive
In età adolescenziale entra al Collegio Navale Francesco Morosini di Venezia, senza però terminare il triennio, concludendo invece gli studi al liceo Istituto Massimiliano Massimo di Roma. Si laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel 1971 e successivamente frequenta alcuni corsi di Diritto Internazionale alla Columbia University di New York. Stando all’ufficio del Registrar della Columbia University, e contrariamente a quanto erroneamente diffuso sul web, non fu mai iscritto a detta università, né, di conseguenza, ha conseguito un Master presso la Columbia University Law School. Inizia la sua carriera lavorando presso lo studio legale Chiomenti di Roma e lo studio Bergreen & Bergreen di New York.
In coppia con l’amico Cristiano Rattazzi, corre diverse gare sui circuiti italiani a bordo di una Fiat 500 Giannini. Inoltre viene registrata una sua partecipazione alla Marathon de la Route al Nürburgring nell’agosto del 1969, a bordo di una FIAT 125 S di serie. L’avventura nei rally internazionali lo vede a fianco di Pino Ceccato, oltre che del già citato Cristiano Rattazzi, alla guida di FIAT 124 S e 125 S; viene chiamato da Cesare Fiorio per correre con la Lancia ufficiale, in coppia con Daniele Audetto. Il primo rally corso dai due è il Rally d’Italia a Sanremo, a bordo di una Fulvia 1600 HF; seguono quello dell’isola d’Elba, quello dei 999 minuti ed il Rally del Medio Adriatico.
La prima esperienza in Ferrari
Il rapporto con Enzo Ferrari inizia allorché il giovane Montezemolo, ospite in una trasmissione radiofonica, difende il “Drake” da un duro attacco, rivoltogli da un radioascoltatore, sui rischi, a dire di costui inutili, di uno sport quale l’automobilismo.
Nel 1973 entra in Ferrari come assistente di Enzo Ferrari e responsabile della Squadra Corse. Sotto la sua gestione la Ferrari vince il Campionato Mondiale Costruttori di Formula 1 per tre anni di seguito, dal 1975 al 1977, e due campionati mondiali piloti con Niki Lauda nel 1975 e 1977.
Le esperienze internazionali
Lascia la Ferrari nel 1977 e diventa responsabile delle relazioni esterne alla FIAT. Ricoprirà questo incarico fino al 1981. In seguito, viene nominato Amministratore Delegato della Itedi, holding che controlla il quotidiano La Stampa e le altre attività del Gruppo FIAT nel settore editoriale.
Tra il 1984 e il 1986 è Amministratore Delegato della Cinzano International, società dell’Istituto Finanziario Industriale (IFI), ed è il responsabile dell’organizzazione della partecipazione all’America’s Cup di vela con l’imbarcazione Azzurra Challenge.
Italia ’90
Dal 1986 al 1990 Montezemolo assume l’incarico di Direttore Generale del comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Calcio Italia ’90. Al termine dei Mondiali, assume la carica di vicepresidente esecutivo della Juventus. Dal 1990 al 1992 ricopre il ruolo di amministratore delegato della RCS Video. Sotto la sua gestione la RCS acquisisce quote della Carolco Pictures. In seguito Montezemolo diventerà membro del Consiglio di Amministrazione di TF1, canale televisivo francese.
Il ritorno alla Ferrari
Torna alla Ferrari nel 1991 in qualità di Presidente, ruolo che ricopre tuttora, e di Amministratore Delegato (incarico che ricoprirà fino al 2006). Ingaggia Jean Todt e, sotto la guida del francese, la Ferrari, dopo 21 anni, nel 2000 torna a vincere il Campionato di Formula 1 con Michael Schumacher. Il successo si ripete anche negli anni successivi: dal2001 al 2004 la Ferrari conquista il titolo Piloti e Costruttori in Formula 1. . Nel 2007 la Scuderia Ferrari conquista nel 2007, per la quindicesima volta, il Titolo Mondiale Piloti e quello Costruttori di Formula 1, nel 2008 vince per la sedicesima volta il Titolo Costruttori.
Altre esperienze imprenditoriali
Dal 1993 al 2005 è vice presidente onorario del Bologna calcio. Tra il 1997 e il 2005 Luca Cordero di Montezemolo assume anche il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato di Maserati S.p.A; per sei anni, fino al giugno 2002, è Presidente degli Industriali della Provincia di Modena e a maggio del 2004 viene nominato Presidente del Gruppo Fiat. Con Diego della Valle dà vita al fondo finanziario imprenditoriale Charme, con il quale acquisisce Poltrona Frau e Cassina nel 2003 e Ballantyne nel 2004. Entra nel consiglio d’amministrazione di Tod’s e fino a luglio 2004 è Presidente della FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali. Il 21 febbraio 2011 ha rifiutato la presidenza del comitato per Roma olimpica.
Nel maggio del 2004 l’Assemblea di Confindustria lo nomina Presidente. Guida per quattro anni, fino al 2008, l’associazione degli industriali.
Altre note biografiche
Da anni si discute di un suo possibile ingresso in politica, tuttavia nel 2003 la sua elezione a presidente di Confindustria smentisce una possibile discesa in campo; al termine del mandato presidenziale, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo possibile ingresso in politica.
Dopo essere stato marito di Sandra Monteleoni (matrimonio annullato), dalla quale ha avuto il figlio Matteo nato il 7 aprile 1977, è stato il compagno di Barbara Parodi Bombrini Delfino, dalla quale ha avuto la figlia Clementina nata il 5 marzo 1981, e poi dell’attrice Edwige Fenech; è sposato dal 7 luglio 2000 con Ludovica Andreoni, dalla quale ha avuto tre figli, Guia nata il 23 aprile 2001, Maria nata il 30 gennaio 2003 e Lupo nato a Roma il 29 luglio 2010.
Secondo il sito finanza.it.msn.com, nell’anno 2009 è stato il quarto manager italiano per stipendio.
Fonte: Wikipedia
Harvey Bernard Milk
Harvey Bernard Milk (Woodmere, 22 maggio 1930 – San Francisco, 27 novembre 1978) è stato un politico statunitense, militante del movimento di liberazione omosessuale. Fu il primo componente delle istituzioni statunitensi apertamente gay.
Fu assassinato insieme al sindaco di San Francisco George Moscone nel 1978 dall’ex consigliere comunale Dan White. Nel 2009 il Presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha conferito alla memoria Milk la massima decorazione degli Stati Uniti, la Presidential Medal of Freedom, per il suo contributo al movimento per i diritti dei gay.
Biografia
Harvey Bernard Milk nacque a Woodmere, Long Island, New York in una famiglia ebraica di origini lituane. Si laureò in matematica all’Albany State College nel 1951 e si arruolò nella marina statunitense; fu congedato con onore, sebbene in seguito egli avesse rivelato agli elettori di essere stato vittima di una delle molte “purghe” di omosessuali nelle forze armate.
Come molte altre persone omosessuali di quel periodo, Milk si trasferì a San Francisco nel 1972, dove si stabilì con il suo compagno Scott Smith e aprì un negozio di fotografia nel quartiere gay di Castro, che divenne un luogo di ritrovo del gruppo che lo avrebbe poi sostenuto nelle elezioni.
Emerse ben presto come un leader della comunità gay, fondando la “Castro Valley Association” dei commercianti locali, e fungendo da rappresentante per gli interessi del quartiere nelle relazioni con il governo cittadino.
A dispetto di un clima ostile a livello nazionale agli omosessuali, si candidò tre volte (senza successo) a cariche elettive. Emerse così come portavoce della vasta comunità gay di San Francisco, venendo per questo soprannominato “sindaco di Castro Street”.
Fu eletto supervisor (cioè consigliere comunale) nel 1977, risultando così il primo rappresentante eletto di una delle maggiori città degli Stati Uniti ad essere apertamente gay.
In undici mesi da supervisor, si batté in difesa di una legge per i diritti dei gay per la Città. Fu decisivo nel rigetto della Proposition 6, supportata dal senatore dello stato Briggs, che avrebbe permesso il licenziamento degli insegnanti dichiaratamente gay in base alla loro identità sessuale. Milk dibatté pubblicamente con Briggs sull’argomento, rivelando arguzia e personalità di fronte alla nazione. Nel novembre 1978 la Proposition 6 fu fermamente rigettata dai californiani.
L’assassinio
Scritta commemorativa nella Harvey Milk Plaza di San Francisco, che recita: se un proiettile dovesse entrarmi nel cervello, allora possa anche distruggere tutte le porte (dell’omofobia) dietro le quali ci si nasconde.
Harvey Milk venne assassinato il 27 novembre 1978 all’interno del Municipio, assieme al sindaco George Moscone, dall’ex consigliere comunale Dan White. White aveva rassegnato le dimissioni pochi giorni prima, a seguito dell’entrata in vigore di una proposta di legge sui diritti dei gay, cui si era opposto.
White sperava di essere riconfermato dal sindaco Moscone, che inizialmente aveva considerato l’idea. Le pressioni della componente più liberale della città spinsero il sindaco a non riconfermare White. White entrò in municipio attraverso una finestra aperta del seminterrato, per evitare di essere scoperto con la pistola e con i 10 caricatori che aveva in tasca. Dopo essersi fatto strada fino all’ufficio del Sindaco, incontrò Moscone e cercò di convincerlo a riconfermarlo. Non riuscendoci gli sparò ripetutamente. White ricaricò l’arma e si aprì la strada fino alla parte opposta dell’edificio, dove incontrò Milk e gli sparò al petto. Milk collassò a terra privo di sensi.White negò la premeditazione.
Un corteo spontaneo a lume di candela per la memoria di Milk e Moscone attirò migliaia di persone, decorato con bandiere arcobaleno.
Milk, consapevole del rischio che correva, aveva registrato numerose audiocassette da ascoltare in tale evenienza.
La sentenza
White fu riconosciuto colpevole di omicidio volontario (imputazione meno grave dell’omicidio premeditato di cui era stato accusato), con l’attenuante della seminfermità mentale, e condannato a sette anni e otto mesi di prigione: una sentenza da più parti ritenuta troppo lieve e motivata dall’omofobia.
Gli avvocati difensori avevano infatti impedito a chiunque fosse favorevole ai diritti dei gay di far parte della giuria. Avevano inoltre chiamato uno psicologo per dimostrare la depressione di White. Lo psicologo a questo scopo argomentò che il consumo di “cibo spazzatura” (quello dei fast-food) da parte dell’imputato era insolito per una persona molto attenta alla forma fisica, ed era quindi un sintomo della sua condizione di abbattimento.
Ciò portò al diffondersi della voce, errata, secondo cui White sarebbe stato giudicato non completamente capace di intendere e di volere come conseguenza del consumo di “cibo spazzatura” in quanto tale. (Al seguito del diffondersi di tale voce, la tattica di sostenere la diminuita responsabilità dell’imputato a causa dell’ingerimento delle sostanze più varie, dalle vitamine al caffè, ha preso, proprio da questo caso, il nome di Twinkie defense).
Dopo la sentenza, la comunità gay si scatenò, inferocita, nelle sommosse notturne contro White dette White Night Riots, in cui più di 160 persone finirono in ospedale.
Dopo la scarcerazione nel 1984, White scontò un anno di libertà vigilata, i primi mesi del quale furono trascorsi nascondendosi a Los Angeles. Ritornò poi a San Francisco, contro l’auspicio pubblico del sindaco Dianne Feinstein, e in questa città si suicidò nel 1985 nel garage della casa di sua moglie, asfissiandosi con i gas di scarico.
Fonte: Wikipedia
Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo (Bonito, 5 giugno 1898 – Firenze, 7 agosto 1960) è stato uno stilista italiano.
Biografia
Salvatore Ferragamo nacque a Bonito in provincia di Avellino. Si dice che la sua passione sia nata dopo aver creato per le sorelle le prime calzature.
Fu uno dei più influenti designer di calzature del XX secolo, popolare anche a Hollywood dove portò con successo le sue creazioni fatte a mano, dal design unico e con grande attenzione al connubio fra bellezza e comodità.
Dopo aver lavorato per un anno a Napoli da un calzolaio, tornò a Bonito, dove aprì un piccolo negozio in cui produceva scarpe su misura per le signore del posto. Nel 1914 partì per gli Stati Uniti per raggiungere uno dei fratelli a Boston, che lavorava in una fabbrica di scarpe. Dopo una breve permanenza si trasferì in California, inizialmente a Santa Barbara, dove aprì una bottega di riparazione e fabbricazione su misura di scarpe. Lavorò per L’American Film Co. e studiò anatomia presso l’Università della California.
In seguito, nel 1923, si spostò a Hollywood, dove aprì l’Hollywood Boot Shop e in poco tempo si guadagnò il nome di “Calzolaio delle stelle”. Anche se alcuni sostengono che le celebri scarpette di rubino di Dorothy, nel film “Il mago di Oz” del 1939, siano state realizzate da lui, in realtà furono una creazione di Gilbert Adrian, famoso costumista di Hollywood.
Dopo tredici anni di attività negli Stati Uniti, ritornò in Italia nel 1927. Si stabilì a Firenze e aprì il suo primo laboratorio in via Mannelli 57. Qui produceva scarpe da donna destinate inizialmente solo al mercato americano. Nel 1928 diede avvio alla prima azienda Salvatore Ferragamo. Il pittore futurista Lucio Venna, nel 1939, produsse la prima pubblicità di Ferragamo e disegnò l’etichetta per le sue creazioni.
Nel 1933, a causa della cattiva gestione amministrativa e della crisi mondiale, la ditta dichiarò bancarotta. Conclusa la guerra, Ferragamo si accorse che il mercato italiano era ancora recettivo. Negli anni cinquanta Palazzo Spini Feroni, dove dal 1938 Ferragamo aveva stabilito la sua sede, divenne meta di attrici del cinema, del jetset internazionale e delle famiglie reali, che venivano nei suoi showroom per ordinare calzature considerate straordinarie per qualità e inventiva.
Ferragamo è stato talvolta indicato come un visionario, con i suoi disegni che spaziano da creazioni più bizzarre, spesso veri e propri oggetti d’arte di altissimo design, a linee di eleganza più tradizionale, che spesso servirono da ispirazione anche ad altri progettisti della calzatura del suo tempo.
Alla morte di Ferragamo, nel 1960, la fama internazionale del marchio non subì flessioni, anzi inaugurò una nuova stagione grazie alla guida della moglie Wanda e dei sei figli Fiamma, Giovanna, Ferruccio, Fulvia, Leonardo e Massimo, che hanno portato avanti sino a oggi l’eredità del fondatore.
L’azienda
Fondata nel 1928 e guidata da Salvatore Ferragamo fino alla sua morte, nel 1960, l’azienda è rimasta nelle mani della famiglia Ferragamo: la moglie Wanda ed i sei figli che, raggiunta la maggiore età, hanno ricoperto i ruoli chiave dell’azienda, contribuendo alla sua espansione sia nell’offerta di prodotti che nella distribuzione.
In vista della quotazione in borsa del marchio, la famiglia Ferragamo è affiancata da un manager esterno, Michele Norsa, che ricopre il ruolo di amministratore delegato.
Tutti i figli ed alcuni nipoti sono attualmente impegnati all’interno dell’azienda e del gruppo:
- Wanda Ferragamo Miletti (Bonito, 1921), moglie del fondatore, è alla guida del gruppo dal 1960 e attualmente ricopre il ruolo di presidente onorario della Salvatore Ferragamo SpA.
- Ferruccio Ferragamo, è attualmente il presidente della Salvatore Ferragamo SpA.
- Giovanna Gentile, è attualmente vicepresidente della holding del gruppo, Ferragamo Finanziaria SpA.
- Leonardo Ferragamo, dal 2000 è amministratore delegato della Palazzo Feroni Finanziaria SpA, la holding company di famiglia.
- Massimo Ferragamo, è il presidente della Ferragamo USA, la società che dagli anni Cinquanta si occupa di distribuire i prodotti del marchio nel Nord America.
- Fulvia Visconti Ferragamo, è dagli anni Settanta responsabile degli accessori in seta del marchio e vicepresidente della Salvatore Ferragamo SpA
- Fiamma Ferragamo di San Giuliano, scomparsa nel 1998, è ancora considerata per molti una figura presente nella vita della Salvatore Ferragamo. Stilista premiata con il Neiman Marcus nel 1967, ha creato alcuni prodotti simbolo del marchio, quali la scarpa Vara e l’ornamento Gancino.
- Nel 1995 a Firenze, Wanda Miletti Ferragamo ha inaugurato il Museo Salvatore Ferragamo, dedicato all’opera del fondatore, dove vengono conservate, tra l’altro, le forme delle scarpe create per molti personaggi celebri. Il 5 dicembre 2006 il museo è stato riaperto in una nuova location a Palazzo Spini Feroni.
Nel 2007 Salvatore Ferragamo sigla con l’americana Timex Group una nuova licenza per i suoi segnatempo. Che dopo il restyling dell’esistente saranno presentati a “Baselworld 2008”.
Il Gruppo Salvatore Ferragamo ha annunciato la sigla del nuovo accordo di licenza per la collezione di segnatempo da ora affidati all’americana Timex Group, fondata nel 1854 e licenziataria di marchi come Valentino e Versace.
Fonte: Wikipedia
Linda Susan Boreman, in arte Linda Lovelace
Linda Lovelace, pseudonimo di Linda Susan Boreman (New York, 10 gennaio 1949 – Denver, 22 aprile 2002), è stata un’attrice pornografica statunitense.
Divenne una delle più famose attrici nel cinema pornografico, recitando come protagonista nel primo film a luci rosse legale della storia, Gola Profonda. Al termine della sua carriera, però, si schierò pubblicamente a fianco delle femministe contro il mercato della pornografia.
Biografia
Linda Susan Boreman nacque il 10 gennaio 1949, nel quartiere del Bronx di New York. Nel 1971 sposò Chuck Traynor, il quale la fece conoscere a Gerard Damiano. Fu quest’ultimo a volerla nel suo film Gola profonda, noto in Italia anche come La vera gola profonda (Deep Throat, 1972). Fu per interpretare questo film, e su consiglio di Damiano, che Linda acquisì il nome d’arte di Linda Lovelace.
Dopo Deep Throat, per il quale ricevette un compenso di 1.250 dollari, la Lovelace recitò in diverse altre produzioni hard, a partire dal sequel, diretto da Joseph W. Sarno, Deep Throat Part II (1974). Nello stesso anno Linda divorziò da Traynor, sposando Larry Marchiano, dal quale ebbe due figli: Dominic nel 1977 e Lindsay nel 1980.
Dopo pochi altri film pornografici, tra cui Deep Throat III, uscito nel 1989 solo in videocassetta, dove comparve non accreditata, la Lovelace fece scalpore rinnegando pubblicamente il genere e schierandosi con le femministe americane contro l’industria dell’hard. Nella sua autobiografia Ordeal dichiarò di essere stata costretta a girare film a luci rosse dal primo marito, descritto come un violento che la picchiava e non aveva esitato a puntarle addosso una pistola.
Nel 1996 divorziò anche dal secondo marito.
Linda Lovelace è morta il 22 aprile 2002 in un incidente d’auto a Denver, in Colorado.
Fonte: Wikipedia